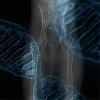Variabilità Genetica e Consanguineità nel CLC
Analisi dei dati genealogici di CLC-Italia

La variabilità genetica è una caratteristica di primaria importanza nell’allevamento. Possiamo dire che essa rappresenta la misura di quanto siano variabili le caratteristiche genetiche e quindi fenotipiche degli individui di una stessa specie, popolazione o, come nel caso dei cani, di una razza. Essa rappresenta il carburante per il motore evolutivo, senza variabilità genetica non c’è cambiamento e quindi adattamento possibile. E’ facile quindi comprendere che per i processi evolutivi naturali una certa misura di Variabilità Genetica è necessaria al fine di garantire a una specie una sufficiente varietà di caratteristiche che gli permettano di adattarsi ai cambiamenti e quindi sopravvivere. In natura è determinata da quei fattori ambientali e casuali che determinano gli accoppiamenti e dalla Selezione Naturale.
Nell’allevamento la Variabilità Genetica è completamente nelle mani dell’uomo, attraverso il controllo degli accoppiamenti (Consanguineità e Selezione). La gestione della parentela (consanguineità) tra gli individui, il rapporto tra omozigosi ed eterozigosi, ha una stretta correlazione con la variabilità genetica (pur non essendone la causa), dalla piccola realtà dell’allevamento fino alla popolazione della razza dove tutte quelle piccole realtà si esprimono come somma attraverso le loro interazioni.
L’omozigosi e quindi la similitudine tra individui sono però alla base del concetto di razza selezionata!
Il Cane Lupo Cecoslovacco nasce in epoca recente da un’ibridazione, quindi da un sistema di accoppiamento che tra quelli possibili è quello che fornisce il più alto livello di Eterozigosi e di Variabilità Genetica. Da allora a oggi è passato relativamente molto tempo, la razza ha acquisito una sua identità morfologica anche grazie all’uso della consanguineità e quindi al conseguente aumento dell’omozigosi e alla diminuzione della Variabilità Genetica.
Conoscere se nel pool genetico della razza esiste, una buona o scarsa Variabilità Genetica è uno strumento importante per comprendere come indirizzare gli accoppiamenti e al riguardo della parentela tra i riproduttori. Da tanto tempo questo dato è carpito empiricamente dall’osservazione, generazione dopo generazione, dall’aumento della similitudine, dalle tare ereditarie palesate dall’omozigosi, e da quei fenomeni detti “depressione da imbreeding”. Tare e depressione sono spesso considerate come lo stesso fenomeno invece è un’associazione sbagliata. Le tare non sono dovute all’omozigosi in se stessa, mentre il loro aumento di frequenza sì. La depressione è invece direttamente collegata a determinati livelli di consanguineità.
Con le moderne tecnologie molecolari a livello di DNA è possibile determinare in maniera scientifica i livelli di omozigosi (Frequenze Alleliche) e quindi anche la Variabilità Genetica attraverso lo studio di un idoneo campione si soggetti della popolazione. Purtroppo nel Cane Lupo Cecoslovacco, ancora non esiste un dato di questo tipo sebbene già nel 2012 fosse nelle iniziative decise e approvate dal Club di Razza, iniziative di cui si è poi perso evidentemente il filo nonostante i proclami di prosecuzione di tali progetti.
Allo stato l’unico tipo di valutazione possibile è quello della stima della consanguineità media attraverso i rapporti di parentela tra soggetti, il COI (Coefficient of Imbreeding).
Qui di seguito è presentata una serie di elaborazioni dei COI ricavati dai dati genealogici di CLC-Italia.it, per ricavarne delle medie annue (che si riferiscono alle nascite) e quindi poterne analizzare l’andamento nel tempo. I livelli di COI espressi riguardano il calcolo della parentela su cinque generazioni. Di norma in zootecnia si usa considerare la consaguineità assoluta (cioè calcolata su tutte le generazioni) in quanto è più indicativa della perdita generale di eterozigosi. Questo è dovuto al fatto che la gestione della Variabilità Genetica in quel contesto è di primaria importanza, mentre nell'allevamento cinofilo il focus è quasi sempre puntato sui risultati dell'accoppiamento piuttosto che le gestione generale della razza, quindi in quest'ottica risulta più utile ragionare sulle cinque generazioni. Giusto per fare un esempio, un COI a livello 0% nelle prime cinque generazione, può arrivare a 15%; un COI del 25% può arrivare a 40% nel calcolo di tutte le generazioni.

E’ stato analizzato un dato della popolazione globale (WD) dal 1982, anno del definitivo passaggio dell’allevamento nell’ambito civile, dal quale si può evincere l’effetto fondatore di Rep che determinò una vertiginosa ascesa del livello medio del COI della popolazione (fino al 1995 quasi totalmente in Repubblica Ceca e Slovacca) da un 4,04% degli ibridi d’interlinea per raggiungere un 21,33% nel 1990. Ricordiamo che il livello del 25% e quello che si determina nell’accoppiamento tra genitore e figlio.
Dal 1990 c’è stata una graduale prima e più deciso poi, discesa della consanguineità fino a giungere nell’anno 2014 a un livello analogo a quello di partenza, un 3,92%. Questo vuol dire che la Variabilità Genetica è tornata quella di prima? Sicuramente no, significa che mediamente la parentela su cinque generazioni dei riproduttori è analoga al periodo pre 1982, che la perdita di eterozigosi non è più cosi forte come nel periodo precedente. Ad esempio un cane nato prima del 1980 che ha 3,3% su cinque generazioni ha 3,5% su tutte le generazioni. Un cane del 2012 con il 4% sulle cinque generazioni, ha 12% nel calcolo assoluto. Ciò che è sicuro che quel periodo di consanguineità abbia prodotto una perdita di Variabilità Genetica, e per avere un parametro di riferimento oggettivo ci vorrebbe appunto uno studio molecolare.
Nel seguente grafico sono confrontati i livelli medi di consanguineità dell’allevamento ceco e slovacco dal 1990. La scelta di questo punto ha diverse motivazioni, la separazione politica della Cecoslovacchia, ma soprattutto perché quell’anno rappresenta il picco massimo di consanguineità dovuta all’effetto fondatore di Rep. Sì, può dire che in quel momento, l’aumento dell’omozigosi fino al livello massimo e la conseguente perdita di Variabilità Genetica ha plasmato a livello genetico (per vederne gli effetti a livello fenotipico ci sarebbero voluti un altro decennio) la razza moderna del CLC come la conosciamo.

L’allevamento ceco rimasto per quanto possibile su un regime di minore consanguineità, grazie anche alla linea di Kazan, parte dal 1990 da un livello del 15% che scende in concreto senza inversioni degne di nota fino ai giorni nostri. Questa discesa è dimostrazione pratica di piani di allevamento attuati allo scopo.
Possiamo vedere come l’allevamento slovacco partendo da un picco di 25%, abbia avuto un andamento a fisarmonica a cavallo del 20% per un altro decennio fino al 2002 con un 23%, per poi cominciare una vertiginosa (e inevitabile) discesa che lo porta nel 2014 al 2,26%, ben di sotto la media globale e per la prima volta nella storia della razza sotto (anche se di pochissimo) al livello dei cechi che si attesta al 2,55%.
Nel prossimo diagramma vediamo invece a confronto la curva della popolazione globale a confronto con quella della popolazione italiana. Il dato della popolazione italiana comincia dal 1998, l’anno in cui è cominciata l’iscrizione al libro genealogico ENCI dei soggetti nati in Italia. Il livello del primo anno, del 12,78%, è più basso della media globale, dato ovvio se consideriamo che i soggetti fondatori della popolazione italiana fossero tutti cechi (che nel 1998 si attesta al 13%) di allevamento e di provenienza ad eccezione dei fratelli Feherlofia, ungheresi figli di cani cechi. Negli anni seguenti la media scende nettamente rispetto al dato globale poiché per fino al 2002 la popolazione si continua a formare su cani cechi e, non essendo adottati dagli allevamenti più influenti accoppiamenti in parentela stretta, il livello del COI rimane simile a quello della popolazione di partenza (mediamente superiore di un punto, o punto e mezzo). Negli stessi anni l’allevamento slovacco raggiunge ancora picchi oltre il 20% alzando la media globale.

Dal 2002 si può notare come la popolazione italiana diventa gradualmente sempre più influente a livello globale, grazie ad un numero di nati in percentuale sul dato globale sempre più elevato. Con il passare degli anni la curva globale si avvicina e si assesta su quell’Italiana con leggeri scarti di livelli superiori nei primi anni, e leggermente inferiori negli ultimi. Possiamo dire che l’allevamento italiano influenza pesantemente la media globale a causa di numeri sempre maggiori.
I livelli di consanguineità si possono ritenere più che accettabili considerando che non esiste nessuna regia di sorta nell’allevamento italiano. Gli allevamenti più influenti numericamente non perseguono veri e propri piani di accoppiamento in consanguineità, anzi. La stragrande maggioranza degli accoppiamenti consanguinei per definizione è attuata da piccole realtà marginali. Considerando la vastità ora dell’allevamento italiano però, queste piccole realtà sono sufficienti ad alzare il livello medio del COI di almeno un punto, senza del quale potremmo essere allineati ai livelli di cechi e slovacchi.
Alessio Camatta
Articolo inserito il 06/08/2015